Qui non c’è il cielo / 7 Febbraio 2016 in Il figlio di Saul
Incubo, clangore, morte, ferro, fuoco, sfuoco. Auschwitz, ‘44. Uno degli ebrei scelti dai nazi come manodopera per perpetrare lo sterminio, detti sonderkommando, è ungherese e si chiama Saul. Insieme agli altri sonderk, accompagna i nuovi deportati alle docce, le ripulisce dei cadaveri, fruga nei loro vestiti rimasti fuori. Li butta nei forni, sparge la cenere nel fiume. Insomma, dai. Un lavoro di me**a. Ok, scusa. I sonderkommando sanno che dopo pochi mesi saranno terminati e sostituiti. Tra milioni, sceglie un cadavere, di un ragazzo sopravvissuto al gas e poi ucciso a mano da un medico, comunque interessato a vivisezionarlo. Il solito approccio analitico teutonico ai problemi. Quello è mio figlio, dice Saul agli altri, e cerca un rabbino per seppellirlo. Ovviamente, da contestualizzare alla situazione in cui si trova, ove tutto è assurdo al punto da lasciare increduli di fronte all’enormità del male, oltre l’umana comprensione; cui si aggiunge lo spento e sotterraneo senso di colpa di prigionieri costretti ad accompagnare altri alla morte. Nemes, conscio delle difficoltà del problema filmico e narrativo che si pone con un soggetto del genere, sceglie di affrontarlo lavorando sul fuori campo: la storia è intessuta di rumori pesanti e metallici, sforzi e fatica, ambienti sfocati sullo sfondo dove il peggio accade, e lì è normale, ed è normale perché è accaduto. Il caos e la paura sono intorno, Saul si muove con fare un po’ grullo nella catena industriale della morte, perseguendo uno scopo che è suo soltanto, a volte con gesti coraggiosi/incoscienti, altre spesso fermandosi a pensare nel bel mezzo del frenetico lavoro nei forni crematori. Per cui ci si aspetta sempre che arrivi un tetesko e gli spari un colpo in testa. La camera segue Saul, e gli altri personaggi, quasi sempre a mezzobusto, di corsa, a spalla, sulle spalle, sulla croce rossa che hanno i sonderk per essere identificabili e al contempo al centro del mirino nell’occhio dello spettatore. E rende il senso di paura, di ignoto, assenza di speranza e morte imminente, quello delle bestie al macello in attesa. Se non ora quando, a breve. Tantôt, direbbe un belga. Gli occhi bassi, ché il cielo è proibito. Il punto forse, oltre al cercare di rendere tale orrore, e le abiezioni e disperazioni di uomini sopravviventi per inerzia, è che lui sceglie, sceglie di provare a “salvare” un morto, non un vivo, andando oltre il concetto di “chi salva una vita salva l’umanità intera”, un simbolo, non è nemmeno suo figlio, Saul non ha figli. Attraversando una collezione di inferni, ma molto ben organizzata. Nel finale, durante una rivolta dei sonderkommando quando si accorgono che a essere stati gassati erano appena stati altri sonderk (accadde nell’ottobre del ‘44), riesce insieme ad altri a fuggire dal campo. Perde il cadavere del ragazzo, perde il rabbino che aveva trovato, e manco era rabbino. Vede un ragazzo, sorride, ed è ca**o ovviamente l’unico sorriso di tutto il film. E basta, le rivolte finiscono male, ad Auschwitz, nel ‘44.
Io non ho più lo stomaco per film così, genere “necessari”.

 Drammatici
Drammatici  Commedie Top
Commedie Top  Tutti gli Oscar
Tutti gli Oscar  Film italiani
Film italiani  Serie TV Drama
Serie TV Drama  Serie TV Comedy
Serie TV Comedy  Le origini del cinema
Le origini del cinema  Spaghetti Western
Spaghetti Western  Cinema & Resistenza
Cinema & Resistenza  NOMINATION OSCAR 2024
NOMINATION OSCAR 2024  Film stasera in TV
Film stasera in TV Film oggi in TV
Film oggi in TV Film oggi in TV
Film oggi in TV Film oggi in TV
Film oggi in TV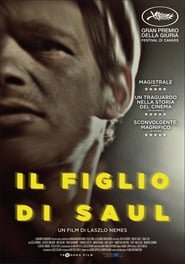



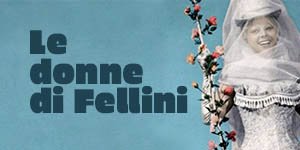








Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.