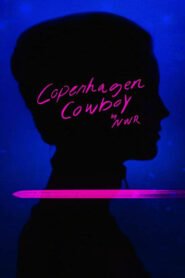Tableaux vivants illuminati al neon / 23 Gennaio 2023 in Copenhagen Cowboy
Prima stagione
Non che la cosa rappresenti una novità, in ambito artistico, anzi, pfui!, ma penso che Copenhagen Cowboy di Nicolas Winding Refn sia un progetto creato dal regista danese come esplicito e inverecondo atto di onanismo. E, per via della condivisione, anche di esibizionismo, va.
Ne deriva che, di tutto ciò, sono stata consapevole guardona.
Refn ha trovato soldi e disponibilità da parte di Netflix, per dare forma (ancora una volta), alle sue ossessioni estetiche, a un’opera televisiva che propone l’ennesima versione dei cliché (narrativi) refniani (l’ultraviolenza, l’eroe solitario e taciturno che cela incredibili capacità, relative influenze giapponesi, la castrazione maschile e il rapporto edipico con le madri, ecc.), a favore di una smaccata ricerca estetica e tecnica (visiva e sonora).
Di film in film, di serie tv in serie tv, l’amico Nicolas sta arrivando al puro allestimento di videoclip o di sessioni fotografiche di moda orchestrati intorno a cupi tableaux vivants illuminati al neon.
I dialoghi sono un mero accessorio.
Cliff Martinez è ancora al comando della consolle musicale.
Le musiche della serie tv alternano con efficacia composizioni strumentali originali del musicista danese Peter Peter a qualche brano vintage (Hold On di Sharon Tandy; Back To The Drive di Suzy Q.).
Ma quel che mi ha colpito in questo apparato musicale rarefatto (e io non ho un sistema dolby in casa, né niente di particolarmente raffinato sotto l’aspetto tecnologico) è la sensazione che alcuni suoni arrivino in maniera “puntuale” dallo schermo (non dalle casse che sono collegate alla tv!), come se ciò che compare in scena (visivamente e uditivamente… si dice?) pulsi, cerchi di sfondare l’apparecchio e invadere la realtà.
Ovviamente, si tratta di una suggestione (sicuramente, indotta se non da questa che non riesco a definire ma da altre scelte tecniche) che, però, con me ha funzionato, mi ha impressionata.
Guardare Copenhagen Cowboy è come sfogliare una rivista patinata di moda o assistere a una sfilata di haute couture.
Gli attori hanno perfino le stesse espressioni scocciate e assenti dei super modelli di (che ne so) Prada in passerella (per l’appunto, il nome dell’eroina protagonista, Miu, deriva da quello di un marchio della maison italiana).
Non è un caso, poi, che Rakel, “la ragazza in rosso” sia interpretata da una delle figlie di Refn, Lola Corfixen, che è, prima di tutto, una modella.
Ma praticamente tutto il cast principale è composto da debuttanti o attori ben poco navigati.
La fissità e la monoespressività dovuta alla loro inesperienza è funzionale all’effetto finale ricercato da Refn.
Non è un caso che uno dei pochi professionisti in scena, Zlatko Buric, che interpreta l’ambiguo avvocato Miroslav (e che aveva già lavorato con Refn alla trilogia di Pusher), sia paradossalmente quasi fuori posto, per gestualità e glosse del viso.
Com’è come non è, io sono rimasta affascinata da questa serie tv, al di là della lunghezza spropositata, dei tempi estremamente dilatati e della “insensatezza” della trama.
Fotografia, composizione scenica e musiche mi hanno ipnotizzata.
Ovviamente, per quanto scarno e volatile sia il tessuto narrativo di Copenhagen Cowboy, sono curiosa di sapere che ne sarà di Miu (Angela Bundalovic) e chi sono questi Giganti di cui si parla negli istanti finali dell’ultimo episodio, voglio conoscere l’entità dei poteri dei “vampiri” e che cosa accadrà allo sgradevole e inquietante Nicklas (Andreas Lykke Jørgensen), che -ogni tanto- grugnisce.
Per ora, non si hanno notizie di un nuovo ciclo di episodi. Speriamo in bene e che Netflix non decida di abortire il progetto.
Voto prima stagione: preferisco sospendere il voto, fino a serie conclusa.

 Drammatici
Drammatici  Commedie Top
Commedie Top  Tutti gli Oscar
Tutti gli Oscar  Film italiani
Film italiani  Serie TV Drama
Serie TV Drama  Serie TV Comedy
Serie TV Comedy  Le origini del cinema
Le origini del cinema  Spaghetti Western
Spaghetti Western  Cinema & Resistenza
Cinema & Resistenza  NOMINATION OSCAR 2024
NOMINATION OSCAR 2024  Film stasera in TV
Film stasera in TV Film oggi in TV
Film oggi in TV Film oggi in TV
Film oggi in TV Film oggi in TV
Film oggi in TV