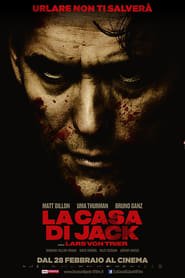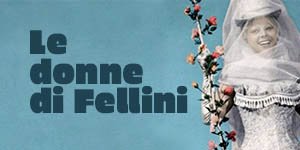La cassa di Jack (premessa) / 2 Febbraio 2022 in La casa di Jack
“La casa di Jack” non è una pellicola, se non all’apparenza, ma un brandello sanguinante che il regista strappa alla realtà. Come giudicare la realtà che è quello che è? Come valutare il regista che pare compiaciuto, se non attratto, dal Male in queste forme estreme, ripugnanti? Certo, Lars Von Trier esibisce e denuncia l’orrore della storia “umana” con il suo ammasso di corpi martoriati, putrefatti, perché la morte è in ogni piega della vita, ma si respira alcunché di morboso, di patologico. E’ l’estetica dell’orrido a trionfare, incardinata in cinque episodi che ricordano i cinque atti della tragedia antica. Jack (Lars) – giustamente Stefania nota il parallelismo fonico e numerico tra i due nomi, come Samsa è un po’ Kafka, nella “Metamorfosi” – è novello Dante la cui catabasi è, però, quella di un dannato, non di un pellegrino. Psicopompo è una figura che ricorda Virgilio.
Per un vertiginoso approfondimento del tema del Male, consiglio di leggere il romanzo “I confini dell’infinito” (vol. I e II)
L’isotopia dell’educazione
Ho riflettuto sull’educazione che i genitori, gli insegnanti, in genere gli adulti impartiscono ai piccoli. Educazione o diseducazione? Io direi che educare, che vale letteralmente, far crescere è molto difficile, se non impossibile: nel 99 per cento dei casi gli educatori falliscono, perché anche solo coniugare la severità con l’indulgenza, la fermezza con la comprensione è impresa ardua. Consideriamo poi gli innumerevoli fattori che influiscono sull’equilibrio psicologico, affettivo e cognitivo del bambino: allevare un figlio in modo saggio e misurato è un po’ come ottenere la “classica quadratura” del cerchio. “Jack”, In realtà, più che un lungometraggio, è una scheggia infuocata nella carne, ma, a parte ciò… accenno al fatto che il protagonista è un omicida seriale tra i più feroci e sadici che un’immaginazione morbosa possa concepire o che la cronaca nera possa descrivere. Naturalmente questo brutale assassino finisce all’Inferno: credo che il regista creda veramente all’Inferno. Io non sono di questo parere, tuttavia non posso escludere che davvero esista una dimensione dove i reprobi sono condannati a soffrire torture indicibili in saecula saeculorum, benché tale possibilità cozzi con l’idea di un Dio che è Amore infinito ed incondizionato. Lars Von Trier – e noi con lui – ci chiediamo: il Male che domina Jack e che lo istiga a perpetrare innominabili sevizie ed omicidi sanguinari, da che cosa dipende? Dal libero arbitrio? Dall’educazione ricevuta? Da altri fattori? O da un concorso di varie circostanze? Mi pare significativo che Jack, ingegnere che, però, avrebbe voluto diventare architetto, dedichi il tempo, tra un massacro e l’altro, a costruirsi una casa, senza mai essere soddisfatto né dei progetti né dell’edificio che comincia ad erigere tanto è vero che ogni volta fa radere al suolo le parti della casa che ha cominciato a costruire.
Ecco! La casa! La casa è anche famiglia; in inglese “house”, casa, e “home”, casa intensa come famiglia, calore familiare, hanno la stessa radice. A Jack è mancata una famiglia che lo amasse, che lo circondasse di affetto, che valorizzasse il suo talento e assecondasse le sue inclinazioni: egli è diventato ingegnere, per volontà dei genitori, pur preferendo l’architettura e, più, in generale l’arte. Sarebbero dunque responsabili i genitori della sua ferocia, eppure è condotto all’Inferno dove Virgilio gli mostra i Campi elisi, una plaga luminosa dove alcuni agricoltori con gesti lenti e solenni mietono il grano. In quella, sul viso del dannato scorre un’amara lacrima: non è rimorso per i suoi mostruosi crimini, ma il rimpianto per un luogo ed una condizione da cui sarà escluso per sempre, perché l’Inferno “etterno dura”.
Pare che il Male assoluto possa essere bilanciato, anche se tardi, solo con le pene infernali, anche se Jack non è del tutto responsabile delle sue scelleratezze. D’altronde non potrebbe aver ereditato questa propensione violenta dai suoi antenati, visto che il DNA contiene una memoria genetica? Sappiamo che gli embrioni sognano: come e che cosa sognano, se non attraverso contenuti archiviati, sedimentati nel DNA silente simile all’“inconscio collettivo” di Jung? Jack è ancora colpevole, sono ancora colpevoli i genitori che non l’hanno saputo allevare? No e sì: no, perché al DNA non si comanda, perché l’ambiente plasma e condiziona; sì, perché, direbbe Dante, ha “sommesso la ragione al talento”, ossia non ha usato la razionalità e la coscienza per dominare gli impulsi distruttivi, trincerandosi dietro alibi e argomenti capziosi sull’assassinio come “arte”. Siamo dunque colpevoli o innocenti? Colpevoli in che misura? Innocenti in che misura? Non lo sappiamo. Sappiamo solo che il buio dell’Inferno – le prime battute del
dialogo tra Jack e Virgilio vengono da un’inquadratura totalmente nera – potrebbe non essere solo una metafora o un espediente cinematografico.
L’isotopia del corpo
Un tema scottante del film “La casa di Jack” è la netta distinzione, di ascendenza gnostica, tra corpo ed anima. Nella Weltanschauung del protagonista tale dicotomia assume un valore per lo più auto-assolutorio: egli ha infierito nei modi più crudeli e sadici contro i corpi, straziandoli, ma ha persino blandito l’intima natura delle sue vittime, quando le ha strette nel suo affettuoso, benché mortale abbraccio. La materia – afferma Jack – è in sé sempre corrotta: essa è putrefazione, disfacimento. Anche ciò che reputiamo apprezzabile, ad esempio, un vino generoso, deriva dalle muffe o dalla decomposizione. Quindi martoriare i corpi non è poi così grave, a differenza di come potrebbe sembrare, perché la stessa natura – non a caso Schopenauer la definisce “mortura” – è tutta tabe, un ripugnante verminaio. Eppure egli è condannato all’Inferno, perché evidentemente la materia non è solo putrefazione, essendo, in una certa misura, partecipe dello spirito e della sua luce.

 Drammatici
Drammatici  Commedie Top
Commedie Top  Tutti gli Oscar
Tutti gli Oscar  Film italiani
Film italiani  Serie TV Drama
Serie TV Drama  Serie TV Comedy
Serie TV Comedy  Le origini del cinema
Le origini del cinema  Spaghetti Western
Spaghetti Western  Cinema & Resistenza
Cinema & Resistenza  NOMINATION OSCAR 2024
NOMINATION OSCAR 2024  Film stasera in TV
Film stasera in TV Film oggi in TV
Film oggi in TV Film oggi in TV
Film oggi in TV Film oggi in TV
Film oggi in TV