La svolta stilistica di Béla Tarr / 7 Febbraio 2016 in Perdizione
Il film della svolta nel cinema di Béla Tarr, che con Perdizione (noto anche come Dannazione, dalla traduzione inglese) impone una decisa e definitiva virata stilistica alla sua regia.
Sebbene Tarr abbia più volte rifiutato il tentativo della critica di incasellare i suoi film in periodi, è innegabile che da un punto di vista di estetica cinematografica ci sia un prima e un dopo Kárhozat.
Lo stile che consacrerà il regista ungherese quale uno degli autori più interessanti, sebbene di nicchia, degli ultimi decenni dello scorso secolo (e del primo di quello nuovo) fa finalmente capolino in questo film dalla trama assolutamente semplice, quasi secondaria rispetto all’intento che emerge di creare un’opera innanzitutto visivamente suggestiva: i lunghissimi piani sequenza, le lente carrellate laterali, l’enorme dilatazione dei tempi.
Ma non si tratta soltanto di esercizi di stile, perché la regia di Tarr è perfettamente calata su una storia mesta e decadente di un’umanità in sfacelo, brutalizzata dalla monotona vita di un non luogo come quello scelto per fare da sfondo alla narrazione: un paesino minerario che sembra un antico teatro di guerra, un luogo in cui piove incessantemente e l’attrazione principale sembra essere la teleferica che muove con inquietante regolarità le benne cariche di carbone. Non a caso il bar del posto si chiama Titanik.
Con Perdizione comincia il sodalizio del regista con lo scrittore Krasznahorkai che curerà la sceneggiatura di tutti i suoi film fino a quello finale, Il cavallo di Torino, dopo il quale Tarr annuncerà il ritiro dall’attività cinematografica.
Un connubio, quello tra Krasznahorkai e Tarr, che ha prodotto quelli che vengono considerati i capolavori del regista (eccetto il modesto L’uomo di Londra, che infatti è sceneggiato da Krasznahorkai ma tratto da un’opera di Simenon).
Eppure in Kárhozat c’è la sensazione che l’affiatamento tra sceneggiatura e resa filmica della stessa non sia ancora ai livelli migliori: i dialoghi sono ampollosi e difficili da seguire, fortemente letterari; la storia non ha ancora quel sostrato di imminente apocalissi che sarà ricorrente da Sátántangó in poi e che costituisce uno dei tratti più suggestivi della poetica cinematografica del regista di Pécs.
È in ogni caso un film interessantissimo, assai difficile – come tutte le pellicole di Tarr – ma che regala alcune scene di una finezza estetica esaltante: come il gelido e meccanico amplesso consumato tra Karrer e la cantante mentre il regista esplora, con un lentissimo e memorabile piano sequenza, l’appartamento della donna. O come l’incipit che, partendo dal paesaggio (con quelle inquietanti benne che trasportano il minerale), si sviluppa con una carrellata indietro che rivela l’occupazione principale del protagonista, che sta ore ed ore ad osservare dalla finestra quel drammatico orizzonte:
“Sono seduto davanti ad una finestra e guardo fuori inutilmente. Sono decenni che resto lì seduto. Qualcosa mi fa pensare che l’attimo dopo impazzirò. Però non impazzisco e non ho paura di impazzire”.
Se non impazzisce, il protagonista ci va molto vicino in quello che è un finale decisamente suggestivo, in cui si ritrova a vagare sotto la pioggia per le campagne fino a mettersi a quattro zampe e ringhiare contro un cane randagio che gli risponde a dovere, ancorché intimorito e (giustamente) sorpreso.
Il mutamento uomo-bestia sembra definitivamente completato.
È un umanità disperata quella caratterizzata da Krasznahorkai, che sembra non avere via di scampo da una vita desolante (la cantante sogna di andarsene da quel posto, ma finirà per concedersi anche al barista).
Soltanto il ballo – un tema ricorrente in Tarr e che vede in questo film la sua teorizzazione – sembra poter rappresentare un veicolo di fuga dalla miseria dell’esistenza (o di fuga dalla follia, come dimostra lo squinternato giovane che balla da solo, dapprima fuori, sotto la pioggia, poi dentro il locale, ma quando la festa è ormai finita e tutto è in disordine).
Eppure il ballo rappresenta anche il mezzo con cui si consuma la prostituzione (morale e poi effettiva) della cantante.
Il ballo che nelle parole della guardarobiera è definito “vortice colorato del divertimento”, “l’insieme d’armonia di mani, gambe, fianchi e spalle che parlano senza parole. Movimenti. Sguardi che sollevano chi balla al di sopra delle preoccupazioni terrene”.
Come sempre Tarr si circonda di attori perfetti nel loro minimalismo, tra cui emergono nettamente i due protagonisti. L’assenza del doppiaggio permette di gustarsi in toto le loro abilità interpretative, con una parlata che, per quanto oscura (vista la lingua originale ungherese), è portata avanti con una pacatezza che esprime tutta la disperazione interiore e la rassegnazione dei personaggi.
Un’ultima menzione per la bellissima fotografia di Gábor Medvigy, un bianco e nero contrastato e così adeguato alle meravigliose quanto grigie ambientazioni, nonché per le musiche di Mihály Vig, che per quanto calzanti non raggiungono tuttavia l’estraniante potenza accompagnatoria di quelle composte per Sátántangó.

 Drammatici
Drammatici  Commedie Top
Commedie Top  Tutti gli Oscar
Tutti gli Oscar  Film italiani
Film italiani  Serie TV Drama
Serie TV Drama  Serie TV Comedy
Serie TV Comedy  Le origini del cinema
Le origini del cinema  Spaghetti Western
Spaghetti Western  Cinema & Resistenza
Cinema & Resistenza  NOMINATION OSCAR 2024
NOMINATION OSCAR 2024  Film stasera in TV
Film stasera in TV Film oggi in TV
Film oggi in TV Film oggi in TV
Film oggi in TV Film oggi in TV
Film oggi in TV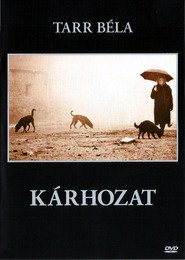












@hartman grande recensione! Mi consiglieresti da quale film cominciare per approcciarmi a questo autore? Ripropongo sempre a me stesso di comprare un suo film, dato che sono facilmente reperibili, tuttavia non saprei quale. So solo che terrò Sátántangó come ultima visione vista la sua durata.
Beh, @jules2517, dovessi consigliare a qualcuno di farsi del male con Béla Tarr (perché di questo stiamo parlando 😀 ) gli direi di partire con Le armonie di Werckmeister, a mio avviso il suo film più accessibile, se si eccettuano i primi lungometraggi che però non avevano ancora quella peculiarità stilistica che lo ha reso celebre tra i cinefili… inoltre ritengo sia anche uno dei più belli…
Unica cosa: sono film molto lenti e faticosi, bisogna esserne consapevoli… non so se hai visto qualcosa di Tarkovskij ma siamo su quella lunghezza d’onda…
assolutamente non consiglio di vederlo la sera tardi o se si è stanchi, perché l’abbiocco è assicurato e si finisce per disprezzare qualcosa che invece meriterebbe una visione più attenta…
@hartman grazie mille! Sí sono consapevole che sia cinema d’autore per persone ‘forti’ di spirito, per questo ho sempre rimandato. Con il tuo consiglio spero di apprezzare questo tanto decantato regista!
L’unico film di Tarr che ho visto finora è Il cavallo di Torino: l’ho metabolizzato con difficoltà, soprattutto per via del senso di profonda angoscia che mi ha lasciato addosso.
sicuramente è un cinema difficile… anch’io fatico molto, non lo nego, ma generalmente mi porto a casa delle buone sensazioni, soprattutto da un punto di vista di estetica dell’immagine, che per me conta molto in un film…
ad esempio nel Cavallo le scene in cui consumano il pasto sono di una potenza visiva a mio avviso unica…
probabilmente il picco artistico, da questo punto di vista, l’ha raggiunto in Satantango…
però a consigliare un film come quello uno rischia di farsi molti nemici, @stefania 😀
@hartman: sì, il rischio è alto 🙂
Perdizione, come tutte le opere di Béla Tarr, è un film per spettatori pazienti e bendisposti. Sfiancante approcciarsi al film se non si è in questa condizione, perché non c’è una trama alla quale appigliarsi per rimanere a galla. Lo spettatore deve naufragare nel film o abbandonare il film. Béla Tarr costruisce uno stile totalmente finalizzato a costruire uno sguardo immersivo, da cui la scelta del bianco e nero, l’uso sistematico di lunghi piani-sequenza e delle carrellate laterali. Per farlo deve prima decostruire qualsiasi illusione narrativa e gli elementi costitutivi del dispositivo cinematografico stesso, cioè lo spazio e il tempo, che qui sono sospesi e svuotati di senso. Il tempo non scorre, immobilizzato, lo spazio non è abitato, ovunque è un non-luogo in cui è impossibile instaurare un vero incontro con l’altro: non ci aiuta la parola (i dialoghi sono vuoti e ampollosi), non ci aiuta l’amore né come sentimento (impossibile) né come atto fisico (gelido e meccanico). Alcuni indizi (cfr. bar Titanic) esplicitano simbolicamente che si tratta di un film sul naufragio, sull’impossibilità di essere umani, di essere qualcosa di diverso dalle bestie e dai cani che corrono vanamente sotto la pioggia, sull’impossibilità di uno sguardo autentico sul mondo. Lo sguardo della camera è infatti sempre inquadrato all’interno di una cornice o è sempre mediato da un oggetto qualsiasi e casuale, immobile, in primissimo piano, che non ha un significato narrativo ma svolge una funzione puramente dialettica di ostacolo al nostro sguardo; la camera ogni volta scivola lentamente di lato, con un movimento naturale, dandoci l’illusione quasi voyeuristica di spiare qualcosa di importante, quando invece non accade nulla che abbia pena guardare. Durante la visione mi sono immedesimato nell’attore della scena iniziale, teso a guardare fuori dalla finestra il nulla che è, il nulla che nietzscheanamente siamo.